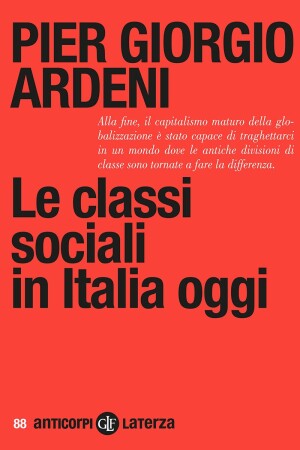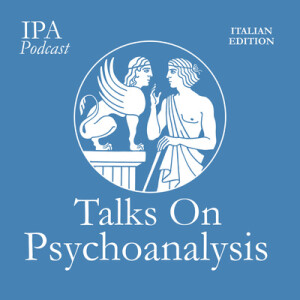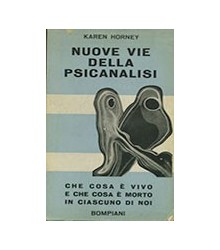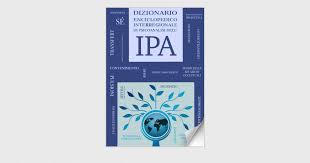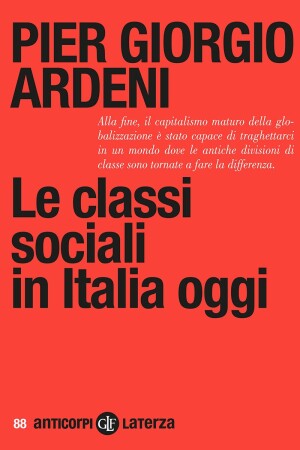 “Il vizio di fondo – ed è questo il messaggio che vorremmo emergesse – è che si è voluto prescindere dall’idea che molte disuguaglianze sono, ancora, dovute alla classe. A ciò si obietta che non ha più senso parlare di classe. È forse vero? Cos’è la classe oggi? Se c’è una differenza che ha ancora un senso è quella più antica di tutte, tra chi è pagato per il lavoro, la prestazione d’opera che svolge, e chi paga. Chi paga esercita un dominio, ha un potere. Chi è pagato può solo negoziare, ma è un “prendere o lasciare”. Chi paga il lavoro svolto da altri ottiene poi un profitto, che è ciò che resta del ricavo una volta pagati i costi. Questa semplice differenza tra chi è pagato e chi paga è ancora all’origine della fondamentale differenza sociale tra le persone, che le accomuna nella loro condizione. Poi, certo, vi sono altre differenze, altre distinzioni, tra lavoro manuale e non manuale, tra lavoro esecutivo e direttivo, tra lavoro specialistico e non. Ma quella fondamentale distinzione è ancora quella che divide le persone in almeno due gruppi, le classi, che condividono una condizione. Chi paga organizza le attività, possiede un capitale con il quale mettere in atto quelle attività. Chi viene pagato, al più, ha la propria forza lavoro (è “manodopera”) o il proprio “capitale umano” (competenze, abilità). Il principale portato ideologico del neoliberismo, contro l’idea delle classi, è proprio questo: che sul mercato siamo tutti “capitalisti”; chi lavora ha un capitale “umano” che vende al miglior prezzo a chi lo pagherà per lavorare. Ognuno è “imprenditore di se stesso”, negozia individualmente le migliori condizioni e tanto più si sa vendere tanto meglio. La individualizzazione del rapporto di lavoro porta così all’abolizione delle organizzazioni di categoria, indebolendo, ovviamente, la posizione dei lavoratori. Ma è rimasta la distinzione – e la divisione – tra chi paga e chi viene pagato per ciò che fa, ed è questa che rende il concetto di classe ancora pregnante. Perché è una condizione collettiva.”
“Il vizio di fondo – ed è questo il messaggio che vorremmo emergesse – è che si è voluto prescindere dall’idea che molte disuguaglianze sono, ancora, dovute alla classe. A ciò si obietta che non ha più senso parlare di classe. È forse vero? Cos’è la classe oggi? Se c’è una differenza che ha ancora un senso è quella più antica di tutte, tra chi è pagato per il lavoro, la prestazione d’opera che svolge, e chi paga. Chi paga esercita un dominio, ha un potere. Chi è pagato può solo negoziare, ma è un “prendere o lasciare”. Chi paga il lavoro svolto da altri ottiene poi un profitto, che è ciò che resta del ricavo una volta pagati i costi. Questa semplice differenza tra chi è pagato e chi paga è ancora all’origine della fondamentale differenza sociale tra le persone, che le accomuna nella loro condizione. Poi, certo, vi sono altre differenze, altre distinzioni, tra lavoro manuale e non manuale, tra lavoro esecutivo e direttivo, tra lavoro specialistico e non. Ma quella fondamentale distinzione è ancora quella che divide le persone in almeno due gruppi, le classi, che condividono una condizione. Chi paga organizza le attività, possiede un capitale con il quale mettere in atto quelle attività. Chi viene pagato, al più, ha la propria forza lavoro (è “manodopera”) o il proprio “capitale umano” (competenze, abilità). Il principale portato ideologico del neoliberismo, contro l’idea delle classi, è proprio questo: che sul mercato siamo tutti “capitalisti”; chi lavora ha un capitale “umano” che vende al miglior prezzo a chi lo pagherà per lavorare. Ognuno è “imprenditore di se stesso”, negozia individualmente le migliori condizioni e tanto più si sa vendere tanto meglio. La individualizzazione del rapporto di lavoro porta così all’abolizione delle organizzazioni di categoria, indebolendo, ovviamente, la posizione dei lavoratori. Ma è rimasta la distinzione – e la divisione – tra chi paga e chi viene pagato per ciò che fa, ed è questa che rende il concetto di classe ancora pregnante. Perché è una condizione collettiva.”
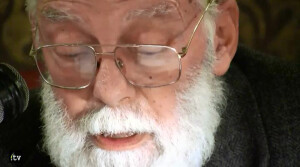 Il transfert è comunque di fatto una resistenza a conoscere l’altro: come se il paziente affermasse di voler solo ri-conoscere qualcuno, ma di non voler conoscere alcuna persona nuova. Il transfert’ è dunque una resistenza alla conoscenza dell’altro in quanto soggetto: e di ciò va tenuto conto proprio nella situazione del colloquio. Quando, in una prima intervista, se abbiamo adottato l’atteggiamento più corretto possibile, andiamo subito benissimo al paziente, oppure al contrario questi dà manifesti segni di non avere alcuna intenzione di proseguire ed intraprendere un’avventura con noi, si vede questo fenomeno in forma tanto evidente quanto poco utilizzabile. Il paziente allora trasferisce su noi affetti o caratteristiche di qualcun altro: ma facendo ciò non può conoscerci.
Il transfert è comunque di fatto una resistenza a conoscere l’altro: come se il paziente affermasse di voler solo ri-conoscere qualcuno, ma di non voler conoscere alcuna persona nuova. Il transfert’ è dunque una resistenza alla conoscenza dell’altro in quanto soggetto: e di ciò va tenuto conto proprio nella situazione del colloquio. Quando, in una prima intervista, se abbiamo adottato l’atteggiamento più corretto possibile, andiamo subito benissimo al paziente, oppure al contrario questi dà manifesti segni di non avere alcuna intenzione di proseguire ed intraprendere un’avventura con noi, si vede questo fenomeno in forma tanto evidente quanto poco utilizzabile. Il paziente allora trasferisce su noi affetti o caratteristiche di qualcun altro: ma facendo ciò non può conoscerci.